 Di Mariafrancesca Natale
Di Mariafrancesca Natale
La tradizione del caffè a Napoli affonda le sue radici in un tempo che è veramente lontano, tanto lontano da averci spinto a chiudere la vera tradizione in quello spazio mentale che si è soliti chiamare dimenticatoio. Ne “I giorni della dimenticanza”, Giuseppe Civati, analizza bene questo aspetto, offrendo spunti di riflessione che vanno molto oltre la dimensione più circoscritta cui vorrei fare riferimento io e spiegando che, in buona sostanza, l’uomo ricorda solo ciò che sta accadendo ora, partendo da una versione distorta di ciò che è realmente accaduto prima dell’ora.
Dicevamo della dimenticanza, questione molto seria, tipicamente italiana e largamente diffusa in un sud che ha fatto dello scordar un’arma per difendersi dalle ingiustizie iscritte ormai nel proprio patrimonio genetico.
Ora, si sa che senza una buona memoria, tutto ciò che pensiamo, può essere soggetto a manipolazioni e, senza una memoria “consapevole”, può accadere che tutto quello che sappiamo, non lo sappiamo veramente ma finiamo col immaginarlo, convincendoci di custodire qualcosa frutto di un processo attivo di acquisizione di conoscenze ma che in realtà è arrivato a noi senza che nemmeno ce ne accorgessimo.
Questo aspetto riguarda molto la questione della qualità del caffè a Napoli.
In ogni bar, in ogni casa, in ogni dove, troverete qualcuno che pensa di custodire il sacro Graal, la ricetta perfetta, per questo segretissima, del caffè magistrale. Ma siamo sicuri che chi pensa di fare il caffè migliore sappia veramente quello che sta facendo? O lo fa perché ha acquisito degli automatismi che non poggiano su nessun apprendimento “introspettivo”?
Se quanto dico è vero, ci si ricorda di non aver mai aperto manuali o libri che effettivamente spieghino le procedure da seguire per estrarre un caffè in modo corretto?
Ebbene, in questi mesi di corsi sull’analisi sensoriale, ho potuto costatare tre cose molto importanti:
1) Le persone, soprattutto gli addetti al settore, sono mossi da grande passione e hanno all’attivo, spesso e volentieri, molti anni di lavoro, che li hanno posti a contatto con il caffè sì, ma già torrefatto;
2) Questi stessi appassionati non hanno mai messo a sistema le nozioni apprese sul campo e, tutto ciò che pensano di sapere o che effettivamente sanno, non sono in grado di spiegarlo e quindi trasmetterlo;
3) Ho potuto sperimentare che una vera cultura, declinata in termini di conoscenze, sia rispetto alla materia prima che poi alla sua preparazione, non esiste affatto, ma è radicato in molti un complesso di conoscenze acquisite per sentito dire o per esperienza, che bypassa lo studio e diviene quasi verità assoluta e scudo necessario.
Spesso, infatti, gli operatori (quelli alla macchina in particolare), hanno sostituito la memoria di come hanno  acquisito determinate conoscenze con la conoscenza stessa, finendo con l’autoconvincersi che ciò che sanno è tutto ciò che è necessario sapere e se gli si fa notare certe defezioni, grosse, in molti casi enormi, arrancano facendo ricorso alla famigerata arte della consuetudine; una sorta di copertina di Linus che ci salva dalla difficile costatazione di non sapere.
acquisito determinate conoscenze con la conoscenza stessa, finendo con l’autoconvincersi che ciò che sanno è tutto ciò che è necessario sapere e se gli si fa notare certe defezioni, grosse, in molti casi enormi, arrancano facendo ricorso alla famigerata arte della consuetudine; una sorta di copertina di Linus che ci salva dalla difficile costatazione di non sapere.
C’è da dire che con garbo e competenza, si arriva ad espugnare anche il più abile “tifoso” della tradizione, riuscendo a stabilire qual complesso, quanto essenziale, punto di incontro con l’innovazione e, soprattutto, la formazione.
Discorso a parte merita chi dal caffè trae il maggior profitto: il torrefattore.
Gli incontri con loro sono stati molto importanti, per capire come si costruisce un concetto che sostanzialmente si rafforza a causa dell’incapacità di ricordare le cose giuste e su una formidabile, ma quasi “ridicola”, abilità nel portare nel futuro solo ciò che serve e che conviene al proprio capitale. Attenzione però, sia ben chiaro, spesso e volentieri le prime vittime di questa dimenticanza sono proprio loro; mentre, in altri casi, la “storiella” del caffè preparato secondo tradizione (che però calpesta la tradizione stessa), viene raccontata, scimmiottata, attraverso un’abilissima comunicazione che diviene mero spettacolo; strategiche valutazioni di mercato volte a manipolare il consumatore per portare nelle proprie tasche l’utile maggiore.
E’ stato illuminate, scoprire, che i loro “sensori” del gusto, erano talmente “starati”, lasciatemi passare il termine, da indurli a loro insaputa ad una serie di errori macroscopici quali, ad esempio, confondere il gusto acido con quello amaro.
 Talvolta, dinanzi a delle tazzine dalla fresca acidità, hanno esclamato “E’ troppo amaro!” per poi rimanere a bocca aperta durante la degustazione guidata. In altri casi, assaggiando le soluzioni, ci sarebbe voluta una quantità di caffeina tale per fargli percepire l’amaro, da rischiare di mandarli al tappeto per sempre.
Talvolta, dinanzi a delle tazzine dalla fresca acidità, hanno esclamato “E’ troppo amaro!” per poi rimanere a bocca aperta durante la degustazione guidata. In altri casi, assaggiando le soluzioni, ci sarebbe voluta una quantità di caffeina tale per fargli percepire l’amaro, da rischiare di mandarli al tappeto per sempre.
Ebbene anche i muri sanno che il caffè è un frutto e quegli stessi muri sanno che il caffè di qualità deve mantenere una certa acidità; fine e delicata, non aggressiva, tipica della frutta, per intenderci!
Eppure molti di loro fanno finta di capirne, salvo poi sostenere che per tradizione il caffè deve essere amaro!
Ma non è tutto, poiché qui subentra il successivo paradosso: la segretissima miscela che deve contenere origini dai flavours cioccolattosi.
E quindi vanno a ruba i caffè da metodi naturali con profili gustativi tendenzialmente più dolci ma, diamine, devono sapere di cioccolato perché alla gente piace così !
Ho impiegato un po’ di tempo a capire come sia possibile pensare, anche solo lontanamente, che un flavour amaro come il cacao possa essere considerato irrinunciabile al fine di ottenere “il caffè dolce”.
La risposta è chiaramente semplice: come loro, anche noi consumatori abbiamo i sensi talmente confusi dal mercato da associare materie prime come ad es. la vaniglia al gusto dolce, poiché un abilissimo quanto subdolo neuromarketing, è riuscito ad espugnare non solo il campo più fragile della mente, condizionandolo e asservendolo, ma anche, ahimè, il tempio per eccellenza: il nostro corpo.
Così il cacao e la vaniglia sono ritenuti sapori dolci, il burro o il tonno si credono salati per natura ecc.
Ora è bene pensare che questo errore, soprattutto se parliamo di gusti, non è solo del Napoletano, ma è il frutto di una tradizione alimentare che influenza profondamente i nostri organi di senso, al punto da confonderli del tutto.
Non sono, purtroppo, genitrice di tale concetto; esiste infatti, una vera e propria disciplina fondata negli anni novanta da D. Howes definita
“antropologia sensoriale”, di cui l’antropologia del gusto – una sua branca – si occupa di analizzare appunto l’influenza del contesto socio-culturale sulla percezione del gusto degli alimenti e sulla sua formazione.
Come se quanto detto non bastasse è necessario riflettere sul fatto che bersaglio prediletto dell’industria alimentare sono sempre più le persone e i loro sentimenti e non più il final consumer inteso come mero richiedente di un certo prodotto. In sostanza, quello che vogliamo è spesso il frutto non della nostra volontà ma il risultato di un’abile e stringente pressione esercitata al fine di spingere le persone ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro.
Allora io invito tutti, soprattutto i consumatori attenti, in particolare i consumatori attenti che bevono caffè, ad approfondire ogni aspetto del prodotto che acquistano.
Non si può, infatti, accettare che vi sia attenzione maniacale finanche per cibi consumati una tantum e non per prodotti come appunto il caffè, bevuti quotidianamente, per molto più di una volta al giorno. Se vogliamo bene a noi stessi ed a quella straordinaria bevanda qual è il caffè, dobbiamo iniziare a porci delle domande e partire alla ricerca delle risposte.
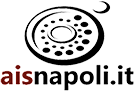
Scrivi un commento